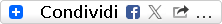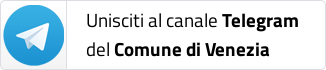Un complesso e monumentale ciclo pittorico realizzato per il Padiglione Centrale dell’Esposizione Internazionale d’Arte del 1907, che racconta l’esistenza in chiave Simbolista: protagonista a Ca’ Pesaro il Poema della vita umana in un allestimento che rievoca la prima esposizione del fregio ai Giardini e che racchiude la visione degli autori del primo Novecento.
Questa mattina alla conferenza di presentazione del progetto espositivo era presente la consigliere delegata Città di Venezia, cultura: attività teatrali e cinema".Giorgia Pea.
“Questa meravigliosa esposizione dimostra ancora una volta quanto questa Amministrazione creda nell’importanza della cultura e dell’arte. Ringrazio i Musei Civici, in particolare Elisabetta Barisoni, per la passione e l’immenso lavoro svolto per portare esposizioni di alto livello, come questa di Sartori- ha spiegato la consigliera Pea- Venezia, come l’arte, è di tutti. L’arte invoglia turisti e cittadini a visitare i nostri musei e Venezia e noi siamo sempre pronti ad accogliere tutti nel pieno rispetto dell’unicità della nostra città”.
Nella primavera del 1906 Aristide Sartorio realizza, su proposta del segretario generale della Biennale, Antonio Fradeletto, il suo capolavoro: un grande ciclo decorativo per il Salone centrale dell’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia del 1907.
Basandosi su un ricco patrimonio di mitologia antica, illustra così il Poema della vita umana. Nel 1909 il Re d’Italia destinò le 14 scene a Ca’ Pesaro che le presenta oggi, restaurate, riunite in questa mostra, a cura di Matteo Piccolo e Elisabetta Barisoni: dal 16 maggio al 28 settembre 2025 il salone centrale del secondo piano della Galleria d’Arte Moderna di Venezia offre una visione in cui il visitatore si può immergere, accolto dalle quattro composizioni monumentali, alternate a dieci teleri verticali, in cui si dispiega una visione drammatica dell’esistenza, personificata dalle maestose figure nate dalla fervida immaginazione dell’artista romano.
Un insieme che ripropone la storica esposizione de La Biennale ai Giardini; le sale adiacenti ricostruiscono il momento storico e rievocano lo spirito del tempo tra opere di artisti coevi a Sartorio, primi fra tutti Auguste Rodin e Max Klinger - presenti nell’allestimento del 1907- Henri Fantin-Latour, Ettore Burzi, Galileo Chini, partecipi del sogno simbolista, del realismo, fino alle soglie delle avanguardie storiche.
Unitamente, trova ampio spazio la documentazione dell’importante restauro a cui il ciclo pittorico è stato sottoposto. Nelle quattro scene principali del Poema della vita umana prende forma un articolato significato di simboli, di indiscusso fascino nella loro complessa e misteriosa interpretazione: la Luce, la prima grande scena che il visitatore incontrava a sinistra, entrando nel salone della settima Biennale; di fronte si stagliano le Tenebre, in cui l’autore rappresenta la lotta della vita contro le forse insidiose della simulazione, una probabile allusione autobiografica in cui Sartorio sferza conto i “presunti amici” del mondo della cultura del tempo. Segue Amore in cui compaiono Venere, Urania e Pandemone, la favola di Amore e Psiche e Himeros - simbolo del desiderio amoroso, opposto ad Eros, il “buon amore”; di seguito nell’allegoria della Morte irrompono i cavalli di Thanatos, le arpie la annunciano, il Sonno di Ypnos la precede.
Una complessa iconografia messa in campo da Sartorio, vista e avvallata anche da Gabriele d’Annunzio, che si snoda come la sintesi tra mitologia mediterranea e cultura nordica: privo di elementi architettonici e risolto in monocromia, il ciclo pittorico affascina per l’eccezionale dispiegamento di figure in movimento che nei teleri delle Tenebre e della Morte assumono forma rotante, a conferma dell’intento simbolico dell’insieme.
“Quando Giulio Aristide Sartorio si impegnò nella grande, titanica impresa di decorare il salone del Padiglione Centrale della Biennale di Venezia, non poteva sapere con certezza quanta importanza quel ciclo decorativo avrebbe avuto per i suoi contemporanei e per gli anni a venire. Il ciclo monumentale arriva a noi come una delle opere più significative di arte decorativa pubblica, a rappresentare il sogno di un un’epoca profondamente simbolista e al contempo la grandiosa esperienza di nascita delle collezioni veneziane d'arte moderna” ha spiegato la curatrice, Elisabetta Barisoni.